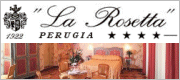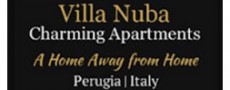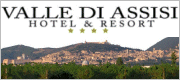Ancora prima di inoltrarsi nel cerchio delle mura del centro storico attraverso la Porta Garibaldi, a nord della città, vicino alla stazione ferroviaria, una scala seminascosta sulla sinistra della porta conduce nel sottosuolo, da dove si può vedere il Ponte Sanguinario, antico ponte romano del I sec. a. C. della Flaminia che attraversava il torrente Tessino, ora interrato perché il Tessino fu deviato successivamente.
Ancora prima di inoltrarsi nel cerchio delle mura del centro storico attraverso la Porta Garibaldi, a nord della città, vicino alla stazione ferroviaria, una scala seminascosta sulla sinistra della porta conduce nel sottosuolo, da dove si può vedere il Ponte Sanguinario, antico ponte romano del I sec. a. C. della Flaminia che attraversava il torrente Tessino, ora interrato perché il Tessino fu deviato successivamente. © William P. Thayer 2000" vspace="3" hspace="3">
Il ponte, largo 4,50 m e lungo 24 m, è a tre arcate, alte 8 m, e costruito in grandi blocchi squadrati di travertino. Il suo nome pare sia una corruzione di „Sandapilarius“, il nome della porta del vicino Anfiteatro, non è da confondere pertanto con il sangue di eventuali martiri cristiani che forse potrebbe aver bagnato l‘arena dell‘anfiteatro.
© William P. Thayer 2000" vspace="3" hspace="3">
Il ponte, largo 4,50 m e lungo 24 m, è a tre arcate, alte 8 m, e costruito in grandi blocchi squadrati di travertino. Il suo nome pare sia una corruzione di „Sandapilarius“, il nome della porta del vicino Anfiteatro, non è da confondere pertanto con il sangue di eventuali martiri cristiani che forse potrebbe aver bagnato l‘arena dell‘anfiteatro.  Sulla Piazza Garibaldi si affaccia la Chiesa di S. Gregorio Maggiore, ricostruita nel 1079 e consacrata nel 1146, al posto di una originaria chiesa con cimitero del IV secolo. Il restauro del 1907 e quello del 1947-50 ha eliminato le modifiche e le decorazioni barocche del 1744, riportando la chiesa al suo aspetto romanico. La facciata è preceduta da un portico rinascimentale (1597), sul quale si apre sulla sinistra la Cappella degli Innocenti, ora battistero, decorata con affreschi del XIV sec., attribuiti agli Angelucci da Mevale. La torre campanaria, iniziata nel XII sec. con dei grandi blocchi di spoglio di monumenti funerari antichi, fu terminata con la cella solamente nel 1492. La facciata, nella parte superiore con le trifore (rinnovate nel 1907) e le nicchie, risale al XIV secolo. La facciata non fa presagire l‘interno a struttura basilicale, a tre navate absidiate, con presbiterio rialzato sopra una cripta, anch‘essa a tre navate, di cui però quella centrale è a sua volta suddivisa in tre navatelle. La rimozione delle decorazioni barocche e delle cappelle rinascimentali ha riportato alla luce frammenti degli affreschi preesistenti, in maggior parte del XV secolo. Nell‘abside centrale si trova un interessante ciclo di affreschi del periodo romanico.
Sulla Piazza Garibaldi si affaccia la Chiesa di S. Gregorio Maggiore, ricostruita nel 1079 e consacrata nel 1146, al posto di una originaria chiesa con cimitero del IV secolo. Il restauro del 1907 e quello del 1947-50 ha eliminato le modifiche e le decorazioni barocche del 1744, riportando la chiesa al suo aspetto romanico. La facciata è preceduta da un portico rinascimentale (1597), sul quale si apre sulla sinistra la Cappella degli Innocenti, ora battistero, decorata con affreschi del XIV sec., attribuiti agli Angelucci da Mevale. La torre campanaria, iniziata nel XII sec. con dei grandi blocchi di spoglio di monumenti funerari antichi, fu terminata con la cella solamente nel 1492. La facciata, nella parte superiore con le trifore (rinnovate nel 1907) e le nicchie, risale al XIV secolo. La facciata non fa presagire l‘interno a struttura basilicale, a tre navate absidiate, con presbiterio rialzato sopra una cripta, anch‘essa a tre navate, di cui però quella centrale è a sua volta suddivisa in tre navatelle. La rimozione delle decorazioni barocche e delle cappelle rinascimentali ha riportato alla luce frammenti degli affreschi preesistenti, in maggior parte del XV secolo. Nell‘abside centrale si trova un interessante ciclo di affreschi del periodo romanico. Da Piazza Garibaldi si sale la Via dell‘Anfiteatro, che per quasi tutta la sua lunghezza è costeggiata dall‘anonima facciata del XIX sec. della Caserma Minervio che sfrutta un vasto complesso conventuale nato nel 1254 come ospedale per poveri, infermi e pellegrini e orfanotrofio, uno dei primi in Europa. Dall‘attuale caserma si può ammirare quel che è rimasto del grandioso Anfiteatro Romano: 10 arcate aperte a volte sono tutto quel che si è conservato di un edificio che originariamnete misurava 115 x 85 m, costruito nel II secolo.
Da Piazza Garibaldi si sale la Via dell‘Anfiteatro, che per quasi tutta la sua lunghezza è costeggiata dall‘anonima facciata del XIX sec. della Caserma Minervio che sfrutta un vasto complesso conventuale nato nel 1254 come ospedale per poveri, infermi e pellegrini e orfanotrofio, uno dei primi in Europa. Dall‘attuale caserma si può ammirare quel che è rimasto del grandioso Anfiteatro Romano: 10 arcate aperte a volte sono tutto quel che si è conservato di un edificio che originariamnete misurava 115 x 85 m, costruito nel II secolo.Nel periodo di Totila, re degli Ostrogoti (541-552), nel 545 fu trasformato in un fortilizio (come accadde al Colosseo di Roma), poi adibito a uso commerciale durante tutto il medioevo, finché non fu ridotto a cava di pietra per la costruzione della Rocca Albonorziana e di altri edifici.
Proseguendo la via, questa cambia nome in Via Cecili. Sulla sinistra, nel basamento della sovrastante Chiesa di S. Nicolò è stata ricavata la Chiesa della Misericordia (inizio XIV sec.), che apparteneva alla confraternita di accompagnamento funebre. All‘interno vi si trovano dei resti di affreschi del XIV e XV sec., da segnalare soprattutto, a destra dell‘altare di S. Michele, „Cristo crocifisso fra la Madonna, S. Giovanni e S. Agostino“, uno dei migliori affreschi del XIV sec. in città.
 Salendo una ripida rampa, si giunge alla sovrastante Chiesa e Convento di S. Nicolò, edificato dagli Agostiniani nel 1304, un importante centro di studi umanistici, dove nel 1512 soggiornò anche Martin Lutero. L‘interno, di semplici forme gotiche, a unica navata, si conclude con un‘abside poligonale con una volta a ombrello, nella quale si aprono delle bifore su una galleria. Restaurata negli anni 1967-74, è stata adibita a centro congressi e spettacoli, mentre l‘ex convento ha ospitato la Galleria Comunale di Arte Moderna, ora trasferita a Palazzo Collicola in piazza Collicola.
Salendo una ripida rampa, si giunge alla sovrastante Chiesa e Convento di S. Nicolò, edificato dagli Agostiniani nel 1304, un importante centro di studi umanistici, dove nel 1512 soggiornò anche Martin Lutero. L‘interno, di semplici forme gotiche, a unica navata, si conclude con un‘abside poligonale con una volta a ombrello, nella quale si aprono delle bifore su una galleria. Restaurata negli anni 1967-74, è stata adibita a centro congressi e spettacoli, mentre l‘ex convento ha ospitato la Galleria Comunale di Arte Moderna, ora trasferita a Palazzo Collicola in piazza Collicola.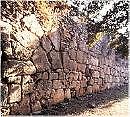 Ritornati su Via Cecili, subito dopo la chiesa, per un tratto lungo 125 metri, sulla sinistra si vede l‘antica Cinta Urbica Umbro-Romana, della quale la parte inferiore è costituita di grandi blocchi poligonali (vedi anche le mura di Amelia) del VI sec. a. C.; lo strato successivo, romano, in quadrilateri, risale al III sec. a. C., mentre il terzo, di parallepipedi bassi e lunghi, fa parte del periodo altomedievale. Una volta persa la sua funzione in seguito alla costruzione di una cinta più ampia resasi necessaria alla fine del XIII secolo, l‘antico muro servì da fondamenta alle case e torri sovrastanti.
Ritornati su Via Cecili, subito dopo la chiesa, per un tratto lungo 125 metri, sulla sinistra si vede l‘antica Cinta Urbica Umbro-Romana, della quale la parte inferiore è costituita di grandi blocchi poligonali (vedi anche le mura di Amelia) del VI sec. a. C.; lo strato successivo, romano, in quadrilateri, risale al III sec. a. C., mentre il terzo, di parallepipedi bassi e lunghi, fa parte del periodo altomedievale. Una volta persa la sua funzione in seguito alla costruzione di una cinta più ampia resasi necessaria alla fine del XIII secolo, l‘antico muro servì da fondamenta alle case e torri sovrastanti.Prima di sfociare sulla Piazza Torre dell‘Olio, sulla destra si ergono due corpi del Palazzo Pompilii (già Virgili) del XV e XVI secolo, che incastonano la Torre dell‘Olio, una torre gentilizia dell‘inizio del XIII secolo.
Essa deve il suo nome alla tradizione che vuole che Annibale sia stato messo in fuga (ecco perché anche il nome della vicina Porta Fuga, del inizio del XIII sec. anch‘essa) in questo luogo dall‘olio bollente versato dagli Spoletini.
 Ora, la cosiddetta Traversa Interna, realizzata tra il 1840 e il 1870, assume il nome di Via Leoni. Sulla sua destra si innalza la Chiesa di S. Domenico, originariamente domenicana, affidata il secolo scorso ai Frati Minori, è sicuramente da visitare per le importanti opere che custodice.
Ora, la cosiddetta Traversa Interna, realizzata tra il 1840 e il 1870, assume il nome di Via Leoni. Sulla sua destra si innalza la Chiesa di S. Domenico, originariamente domenicana, affidata il secolo scorso ai Frati Minori, è sicuramente da visitare per le importanti opere che custodice.La Via Leoni ora si immette in Piazza Collicola, sulla quale si affaccia il Palazzo Collicola, costruito nella prima metà del XVIII sec. da Sebastiano Cipriani. Dietro la facciata scandita da tre ordini di arcate, due ali, di cui una rimasta incompiuta, racchiudevano un giardino all‘italiana, ora adibito a parcheggio. Al piano nobile, il palazzo, ora sede scolastica, conserva delle decorazioni a tempera con paesaggi e motivi architettonici.